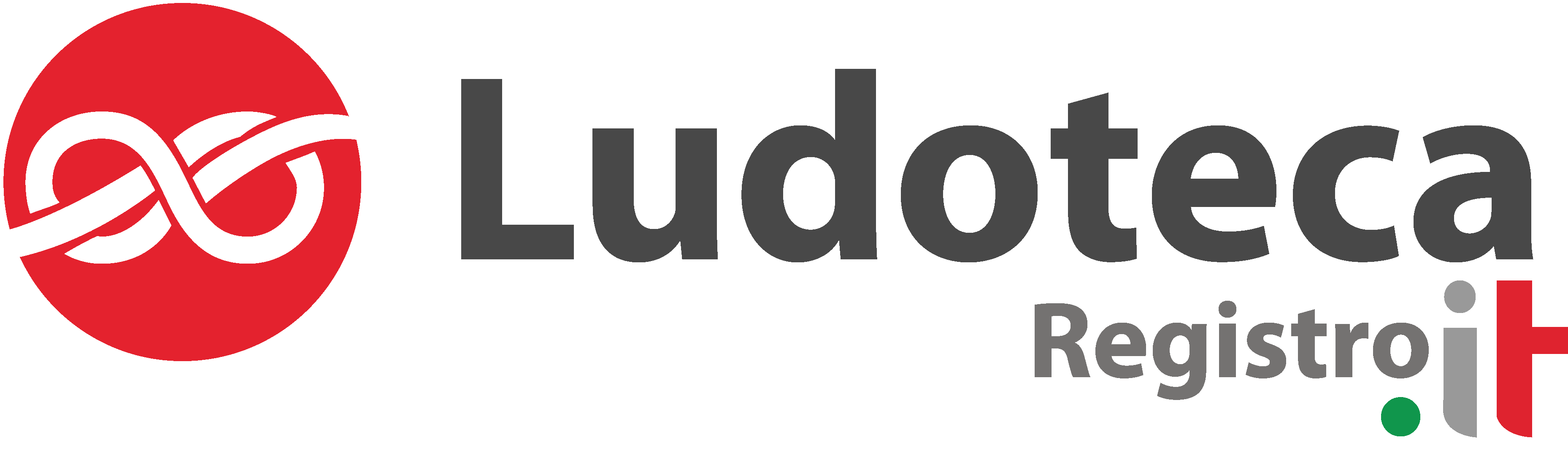Domenico Laforenza – Cittadinanza digitale
Domenico Laforenza, associato emerito del Consiglio Nazionale delle ricerche e direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, in questo webinar spiega cosa si intende per cittadinanza digitale e quali sono le componenti principali della carta della cittadinanza digitale, a partire dal termine cittadinanza, condizione giuridica e sociale di chi appartiene ad uno Stato e che prevede il bilanciarsi di determinati diritti e determinati doveri di natura sociale, politica, civile, ecc. Nel caso della cittadinanza digitale, tali diritti e doveri derivano dalle tecnologie digitali e semplificano il rapporto tra cittadini, imprese, liberi professionisti e pubblica amministrazione.
CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale
La cittadinanza digitale nasce in virtù del decreto-legge numero 82 del 2005, che è dedicato al CAD, il Codice dell’Amministrazione Digitale. È un testo unico che unisce e organizza tutto quello che riguarda l’informatizzazione della pubblica amministrazione. È stato rivisto e modificato più volte, prima nel 2016 e poi nel 2017, per introdurre il concetto di carta della cittadinanza digitale e per promuovere e rendere effettivi i diritti e i doveri che ne conseguono. Questa legge si compone di 92 articoli che contengono definizioni di concetti come “documento informatico” e “firma elettronica” ed elencano le regole tecniche, ossia i principi che la pubblica amministrazione deve implementare per gestire, conservare e trasmettere i documenti delle persone e delle aziende.
Le modifiche al decreto-legge
Il CAD nel 2017 è stato modificato, definendo al suo interno ancora più chiaramente i diritti e i doveri dei cittadini e nei confronti della pubblica amministrazione. Nell’articolo 3 comma 1 della seconda sezione del decreto-legge si sostiene che l’innovazione debba servire anche e soprattutto a rendere più facile la vita del cittadino e a sollevarlo dal dover inseguire l’amministrazione pubblica. Per questo è diritto di tutti i cittadini e tutte le imprese accedere ai documenti e ai servizi di loro interesse in maniera totalmente digitale, così da evitare le problematiche tipiche dell’accesso fisico. A questo si aggiunge che le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere più volte ai cittadini e alle imprese le informazioni di cui sono già in possesso, secondo il principio del “once only”. Questo porterà a meno code, risparmio di denaro, velocizzazione dei processi, meno traffico e meno inquinamento.
I pilastri della carta della cittadinanza digitale
La carta della cittadinanza digitale, citata nel decreto-legge 217, si basa su alcuni principi: il domicilio digitale, lo spid, che corrisponde alla carta d’identità elettronica, l’anagrafe nazionale della popolazione residente, la tessera sanitaria estesa come carta nazionale dei servizi, la firma digitale, i pagamenti digitali e la figura del difensore civico digitale unico.
– Il *domicilio digitale* è un recapito online che i cittadini, le imprese e i professionisti indicano alla pubblica amministrazione per ricevere digitalmente comunicazioni che hanno valenza legale. Per scegliere il proprio domicilio digitale si deve disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata, che il Comune può inserire nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, così che sia disponibile a tutte le amministrazioni.
Tra i vantaggi del domicilio digitale: la popolazione italiana potrà ricevere le comunicazioni aventi valore legale tramite pc, tablet o smartphone e la dematerializzazione, che implica minori sprechi di carta e un minor inquinamento. Per rendere efficace questo strumento si è dovuto superare, il problema dell’accesso alla grande quantità di siti della pubblica amministrazione, ognuno dei quali richiede un account comprensivo di User-ID e password da ricordare. È stato quindi creato lo *SPID*, il “sistema pubblico di identità digitale”. Tramite l’utilizzo di una sola coppia di credenziali User-ID e password, ci consente di entrare nell’ecosistema di tutto ciò che oggi è disponibile come pubblica amministrazione. Si può richiedere seguendo le indicazioni presenti sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e rivolgendosi alle aziende accreditate , chiamate “identity provider”.
– La *carta d’identità digitale* o elettronica, in breve CIE, è un altro strumento utile per l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Tutti i cittadini muniti della carta d’identità digitale di nuova generazione, emessa dal poligrafico e dalla zecca dello Stato, hanno quindi a disposizione una coppia User-ID e Pin con cui possono accedere a diversi servizi.
– Si aggiunge allo SPID e alla carta di identità elettronica la *carta nazionale dei servizi*, detta CNS, che estende la tessera sanitaria, attraverso un chip, e permette anch’essa di accedere a servizi della pubblica amministrazione.
– La *firma digitale* è utile a garantire l’identità di chi invia i documenti. È, di fatto, l’equivalente di una firma autografa con valore legale, con cui si possono firmare tutti i documenti digitali. Questa si basa su metodi matematici e protocolli di natura crittografica, in grado di verificare tre cose importantissime: che il mittente del messaggio sia chi dice di essere, ossia l’autenticazione; che il mittente non possa negare di averlo inviato, “non ripudio”; e, infine, che il messaggio non sia stato alterato nel percorso che va dal mittente al destinatario, in quest’ultimo caso si parla di potenza e funzionalità della firma digitale, che garantisce l’integrità del messaggio inviato.
– IO è un’applicazione, molto usata nel 2021 per accumulare un bonus sui pagamenti effettuati con carta di credito, che consente di accedere all’intero ecosistema della pubblica amministrazione da un’unica piattaforma. Un pilastro importante del CAD sono, infatti, i *pagamenti effettuati in forma digitale*, più sicuri e che evitano forme di frode ed evasione fiscale.
– Ultimo pilastro della carta della cittadinanza digitale è il *difensore civico per il digitale*. Il suo ufficio si trova fisicamente e virtualmente presso l’AgID e ha due compiti fondamentali: raccogliere le segnalazioni relative a presunte violazioni del codice dell’amministrazione digitale e raccogliere le contestazioni relative all’accesso ai siti web della pubblica amministrazione e altre attività.